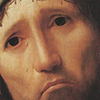Esodo
![]()
![]() Cap 2,1-15a
Cap 2,1-15a
Mosè: il personaggio che Dio prepara per la salvezza d’Israele (Esodo 2, 1-15a)
I. Note introduttive
– La presente « lettura biblica» è rivolta alla pagina del libro dell’Esodo, che va da 2,1 a 2,15a
– In questa·pagina ci imbattiamo per la prima volta nel personaggio Mosè, che d’ora in poi dominerà l’intero svolgimento dei racconti contenuti nei libri del Pentateuco.
– La figura di Mosè riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della tradizione ebraica; questa gli ha voluto attribuire tutti quei caratteri che servono a ricondurre a lui l’origine dell’intera storia del popolo nei suoi vari aspetti: Mosè viene considerato come l’autore del Pentateuco, il fondatore della religione d’Israele, il promulgatore della Legge, l’organizzatore del popolo e del culto; a seconda delle tradizioni, poi, egli viene identificato come capo carismatico, profeta, sacerdote…
Indicazioni per una lettura spirituale
La «bellezza» di Mosè e l’umorismo di Dio
La nascita di Mosè accade proprio nel momento in cui più violenta si sta scatenando la cupa offensiva del faraone: «Ogni figlio maschio che nascerà agli Ebrei, lo getterete nel Nilo! » (1,22). Ma ecco farsi avanti, con la dignità silenziosa dei personaggi umili e privi di contorni definiti, un
« uomo della famiglia di Levi », che ha il coraggio di opporsi a questa violenza scatenata: con risoluta determinatezza egli «andò a prendere in moglie una figlia di Levi» (2,1); costei ben presto concepirà e partorirà un figlio: Mosè. L’autore biblico ci dice che quando Mosè venne al mondo la madre « vide che era bello » (2,2). Con questo aggettivo non si vuole connotare tanto l’avvenenza o la prestanza fisica del neonato, quanto piuttosto se ne vuole indicare la fondamentale prerogativa teologica. Mosè è «bello» come sono «belle» tutte le creature che escono dalle mani di Dio, secondo il racconto della creazione: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco: era tutto molto bello» (Gen. 1,31; cfr. 1,4.10.12.18.21.25). La bellezza di Mosè è il segno che Dio stesso sta avviando il processo di una nuova opera creativa; nelle tenebre fosche stese sulla terra dalla prepotente oppressione del faraone si apre uno spazio di chiarore. In un bambino che nasce si puntualizza tutta la potenza del creatore, che sta ormai plasmando la sua nuova e singolare creatura: il popolo d’Israele. Per questo il neonato Mosè è « bello»: come sono belle tutte quelle creature in cui la speranza degli uomini riesce ad intravedere lo splendore luminoso delle opere che nascono per intervento del Signore. Tutto qui si svolge nel modo più imprevedibile: il neonato, deposto sulla riva del Nilo, susciterà la simpatia e il favore della figlia del faraone (cfr.2,3-6); quindi, dopo essere stato allattato dalla madre, sarà addirittura allevato a corte, protetto dalle cure benevoli della figlia del faraone, e considerato come un figlio per lei (cfr. 2,7-10). Non c’è dubbio che, quando Dio crea le proprie opere, egli combina tutto a modo suo, fino al punto di conferire ai propri interventi una tipica nota umoristica. È con un certo gusto per l’ironia, infatti, che l’autore del nostro racconto ci fa assistere al capovolgimento di tutte le pretese maligne del faraone: la stessa corte del sovrano d’Egitto sarà il luogo in cui Mosè verrà addestrato e preparato all’impresa della liberazione d’Israele! Non solo: proprio quelle acque del Nilo che dovevano inghiottire tutte le speranze degli Ebrei (cfr 1,22), saranno il segno della grande salvezza che Dio sta operando per il suo popolo a causa .della miracolosa sopravvivenza di Mosè: «La figlia .del faraone lo chiamò Mosè, dicendo: “Io l’ho salvato dalle acque!”» (2,10).
Sembra quasi che l’intervento di Dio creatore consista in una spettacolare presa in giro di tutti i faraoni di questo mondo, ridicolizzati proprio in quegli aspetti di intransigente durezza e di radicalismo fanatico ,che ne fanno i più cupi oppositori del piano di Dio nella storia. È così che, diffondendo sulla storia umana i riflessi del suo sorriso, Dio ribalta dall’interno le intenzioni malvagie dei cuori umani e ne fa degli strumenti – spesso inconsapevoli – della propria opera di salvezza. La creazione del mondo, è davvero il frutto di un Dio umorista, che sa piegare al bello le opposizioni umane, così come fa risplendere sul volto di Mosè la bellezza della sua nuova iniziativa, che condurrà alla creazione d’Israele, suo popolo, e alla sconfitta clamorosa del faraone.
Mosè, il giustiziere
Divenuto adulto, Mosè si sente animato da forti sentimenti di solidarietà nei confronti dei «suoi fratelli ››; convinto del proprio dovere di impegnarsi a loro vantaggio, egli «si recò dai suoi fratelli e notò i lavori pesanti da cui erano oppressi» (2,11), In tal modo Mosè ritiene di avere scoperto il proprio campo d’impegno sociale e politico; ed egli è pronto addirittura ad uccidere un egiziano, pur di dare sfogo agli entusiasmi della sua nuova vocazione (cfr. 2,11 s.). Non c’è dubbio che Mosè sia una persona generosa; come capita a molti tra coloro che la storia umana ha privilegiato con doni materiali e con doti di cultura fuori del comune, egli è forse vittima della propria astrattezza intellettualistica, ma non è possibile negargli una costitutiva generosità. C’è però qualcosa che Mosè ha dimenticato, o che forse non ha ancora capito: non basta sentirsi animati da furori rivoluzionari o da idealismi solidaristici per ritenersi depositari di una vocazione da parte di Dio.
E finché Dio non chiama, ogni nostro impegno è destinato a sfumare miseramente nell’inefficacia del più squallido intellettualismo!
È quanto capita anche a Mosè, a cui qualcuno chiederà con pungente risentimento: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi, come hai ucciso l’egiziano? » (2,14). Chi ha legittimato quella vocazione di salvatore del popolo, che Mosè si è assunta di sua iniziativa? Chi è Mosè per ritenersi detentore della giustizia concernente il suo popolo? Chi lo ha nominato giustiziere? E sono appunto i suoi stessi «fratelli» che rifiutano la generosità del suo intervento, perché avvertono che questa sua giustizia non potrà mai generare frutti di vita, ma soltanto altre uccisioni, altre morti, altre prepotenze. La giustizia di Mosè, autonominatosi giustiziere, è ancora chiusa entro la logica del potere autoritario ed intellettualistico.
Quando Mosè si rende conto di ciò, tutto sembra crollare dentro di lui: egli «ebbe paura e pensò:
” Certamente la cosa si è risaputa” »(2,14). Mosè si accorge di non essere altro che un uomo tra i tanti, un Ebreo tra i tanti, una persona priva di potere in una moltitudine di persone prive di potere. Tutti i privilegi che gli derivano dalla sua cultura superiore, dalla sua coscienza più raffinata, dalle sue scelte più critiche, vengono meno in un baleno e il povero Mosè è costretto a demistificare ogni sua presunta vocazione. È necessario che Mosè impari a proprie spese che nessun impegno umano – nemmeno il più generoso o apparentemente disinteressato – può camuffarsi da impegno sacro, assumendo le prerogative che competono soltanto alla chiamata che Dio stesso rivolge alle persone da lui scelte.