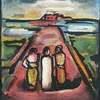La Via 6 gennaio
DIO E’ VENUTO FRA NOI (Mt 2,1-12)
Epifania è una parola greca che significa «manifestazione». E il
tema delle letture della liturgia di oggi è appunto la manifestazione
di Gesù. Nel racconto evangelico (Mt 2,1-12) Gesù è rivelato
come re. I Magi arrivano a Gerusalemme e chiedono:
«Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei?». Dunque Gesù è re.
Matteo ha però cura di collocare questo titolo in un contesto di
opposizione. Accanto al re Messia c’è il re Erode. E il secondo ha
paura del primo, come già un tempo il faraone d’Egitto ebbe
paura dei figli di Israele e ordinò di ucciderli. Solo che ora ad
avere paura del Messia non è più l’Egitto, ma lo stesso Israele
(«Il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme»).
L’Epifania non manifesta soltanto la regalità di Gesù, ma anche
la sua universalità. I Magi sono le primizie dei pagani che incontrano
la salvezza. L’Epifania è la manifestazione pubblica, universale,
della salvezza di Cristo: il segno che il Messia non è venuto
soltanto per Israele, ma anche per i pagani. Cristo è per
tutti. Il racconto di Matteo è un continuo rinvio, a volte esplicito
e alle volte velato, a una linea di passi anticotestamentari che
già imprimevano all’elezione di Israele una direzione di universalità.
Chiarissimo in proposito è il passo di Isaia che costituisce la prima
lettura di oggi (60,1-6) nel quale si descrivono i popoli che
arrivano a Gerusalemme con tutte le loro ricchezze. È una lettura
da non trascurare Il tema dell’universalità è ribadito anche da Paolo (Ef 3,2-6,
seconda lettura): il mistero di Dio – tenuto nascosto e ora svelato
– è il progetto di riunire in una sola famiglia «giudei e pagani
». Le genti, cioè, «sono chiamate in Cristo a condividere la
stessa eredità, a formare lo stesso corpo». La venuta dei Magi
è appunto l’inizio di questa riunificazione. Dunque l’Epifania è
una festa di universalità: una festa insieme cristologica ed ecclesiale.
La luce che unifica è Cristo. Ma segno, anticipo e strumento
di riunificazione di tutta l’umanità è la Chiesa. Suo primo
compito è imprimere alla storia un movimento di riunificazione.
Compito che deve svolgere a due livelli, contemporaneamente:
annunciare a tutti i popoli il vangelo per riunire tutti
nell’unica fede; aiutare gli uomini, mentre sono ancora divisi
in differenti fedi, ideologie, politiche, a trovare punti di contatto,
di unità, di convivenza pacifica e fraterna.
Il racconto di Matteo non si accontenta di proclamare il significato
universale e missionario della venuta fra noi del Figlio di
Dio, ma svela, anticipandole, alcune di quelle direzioni e di
quelle tensioni che, da una parte, costituiscono i tratti più caratteristici
della fisionomia di Gesù e della successiva missione
cristiana, ma che, dall’altra, sono apparsi (e continuano ad apparire)
come inaspettati, se non addirittura scandalosi.
Gesù – afferma l’evangelista – è un Dio venuto fra noi, ma la
sua gloria è racchiusa in un’apparenza di sconfitta. Sulla sua
strada non ci sono soltanto i Magi che lo cercano. Ci sono anche
Erode e Gerusalemme che, alla notizia della sua nascita, si
turbano. C’è chi lo cerca per adorarlo e chi lo cerca per ucciderlo.
Gesù è colui che l’Antico Testamento attendeva, in lui si
compie l’attesa dei popoli, in lui le speranze degli uomini trovano
il loro fondamento: questa è la lieta notizia. Ma il portatore
della lieta notizia ha il volto di un profugo: deve fuggire in
Egitto. È un tratto del tutto inatteso: il Messia porta un messaggio
di speranza e tuttavia è abbandonato alla violenza degli
uomini.
Bruno Maggioni